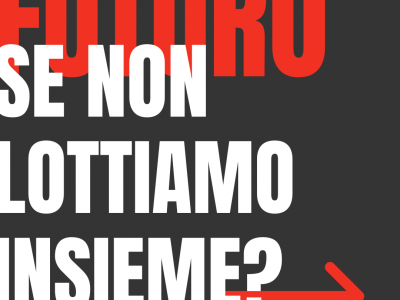
Da mesi, in tutte le sedi territoriali dell’ADI, nelle assemblee, negli incontri pubblici e nei momenti di confronto nei luoghi della formazione e della produzione scientifica registriamo una crescente e diffusa preoccupazione che serpeggia tra le componenti più giovani della comunità accademica: dottorandi/e, assegnisti/e, ricercatori/trici. Tale preoccupazione esistenziale, che è pure la nostra preoccupazione da precarie e precari, nasce dalla concreta prospettiva di un’ulteriore precarizzazione del lavoro di ricerca nel nostro Paese.
Sotto la retorica della “flessibilità a ogni costo e a tutti i costi” o, più di recente, della “economicità”, indicata da taluni come condizione necessaria alla sopravvivenza del sistema accademico italiano, si cela una realtà profondamente iniqua: decine di migliaia di giovani sono posti dinanzi a un bivio inaccettabile – da un lato, condizioni di lavoro prive delle tutele giuridiche fondamentali, completamente insostenibili già nel breve-medio periodo; dall’altro, l’espulsione dal mondo della ricerca.
In tale contesto, la ferma opposizione al disegno di legge S. 1240/2024 (la cd. “Riforma Bernini”) non è tanto una mera intestazione ideologica, ma rappresenta una presa di posizione imprescindibile a difesa del futuro della ricerca pubblica in Italia, inteso primariamente quale futuro di chi materialmente svolge il lavoro di ricerca nel nostro Paese e lo fa provenendo da background socio-economico-culturali differenti. Tale provvedimento, infatti, si configura come una riproposizione in peius delle principali criticità che affliggono da anni il sistema del preruolo universitario: assenza di tutele giuslavoristiche, cronica instabilità occupazionale, ricorso sistematico a tipologie di lavoro parasubordinato o de-strutturato a termine, inadeguatezza retributiva, mancanza di prospettive professionali. Problemi noti e denunciati da tempo in ogni sede – istituzionale e pubblica – anche attraverso il costante lavoro di monitoraggio condotto dall’ADI con le proprie indagini annuali, che restituiscono un quadro sempre più allarmante delle condizioni materiali in cui si svolge il lavoro di ricerca in Italia.
Nonostante l’impegno costante nel rappresentare la voce della componente più fragile del sistema universitario, la Ministra Bernini, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e una parte considerevole delle governance accademiche e della componente strutturata dell’università italiana continuano a non prestare ascolto, ovvero a riproporre (o a far riproporre) argomenti fallaci che tradiscono o celano una visione diversa del futuro della ricerca.
Le cause profonde di questa condizione sono note, e hanno assunto nel tempo le forme giuridiche dell’assegno di ricerca e della borsa. Ma il nodo di fondo è uno, e va ribadito con forza: almeno il 40% di chi lavora nella ricerca in Italia non ha avuto fino ad ora un vero e proprio contratto di lavoro.
È forse necessario ricordare, ancora una volta, che in questo Paese chi svolge attività di ricerca è escluso dalle tutele minime previste dalla normativa generale in materia di lavoro e garantite a livello europeo e OCSE: diritto alla maternità e alla malattia, congedi per motivi familiari, copertura pensionistica in regime pubblico, protezione dai licenziamenti illegittimi, livelli retributivi dignitosi.
Riconoscere questi diritti non è un privilegio: è un dovere costituzionale e un presupposto essenziale per restituire dignità, sostenibilità e futuro alla ricerca pubblica in Italia.
Per oltre due anni, il Governo italiano – in particolare nella persona della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – ha deliberatamente sospeso l’attuazione dell’unico strumento che avrebbe potuto segnare un primo, significativo avanzamento verso il raggiungimento di standard europei per il lavoro di ricerca nel preruolo: il contratto di ricerca promosso dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Questo è avvenuto proprio nel momento in cui il sistema universitario italiano beneficiava di un’ingente immissione di risorse straordinarie attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), risorse vincolate proprio all’attivazione di forme contrattuali innovative e più garantite per il personale di ricerca attraverso il contratto di ricerca.
Il contratto di ricerca, rimasto inattuato negli atenei fino all’emanazione del decreto direttoriale 24 febbraio 2025, n. 47, è stato da subito osteggiato dalla canea di chi vedeva nella sua introduzione una presunta minaccia di “stabilizzazione impropria” del personale precario, nonché da chi considera superfluo – se non dannoso – il riconoscimento di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dal quadro europeo della ricerca: contribuzione previdenziale e assistenziale piena, tutele in materia di genitorialità, accesso agli ammortizzatori sociali previsti per il lavoro subordinato.
A fronte di ciò, si è assistito al tentativo, malcelato quanto goffo, da parte della Ministra Bernini e del gruppo di lavoro da lei nominato, di reintrodurre e mimetizzare – sotto nuove etichette e con minori garanzie – modelli para-contrattuali già noti e superati, come l’assegno di ricerca, affiancati da ulteriori forme paracontrattuali a tutele decrescenti. Tale operazione si è accompagnata ai più drastici tagli al sistema universitario degli ultimi quindici anni, contribuendo a minare alla radice ogni prospettiva di riforma strutturale. Con ciò, è stata la stessa Ministra – sostenuta da quella parte di accademia che invoca “flessibilità” come non-detto di demansionamento – a smentire la narrazione secondo cui l’introduzione del contratto di ricerca avrebbe comportato, per necessità, l’espulsione dal sistema accademico per ragioni di sostenibilità economica. Si continua così a dare per scontato, erroneamente, che la proliferazione di tipologie para-contrattuali, precarie quanto atipiche nell’intero panorama della ricerca europea, sia l’unica risposta possibile al precariato strutturale, ignorando soluzioni alternative, già praticate in altri ordinamenti, fondate su scelte politiche e normative di ampio respiro.
In verità, Il disegno di legge AS 1240/2024 disvela una strategia sistemica e scientificamente riproposta dagli architetti che dapprima hanno congegnato la Legge Gelmini e, ora, il DDL Bernini: un modello di in-accesso alla carriera accademica fondato sullo sfruttamento protratto di una vasta platea di giovani altamente qualificati – dottori e dottoresse di ricerca, assegnisti, ricercatori a tempo determinato, adjunct professor, borsisti post-lauream – destinati a rimanere per decenni in una condizione di subordinazione e subalternità priva di diritti, spesso sino alla soglia dei cinquant’anni, nonostante curriculum di eccellenza. Il passaggio dall’assegno di ricerca al contratto di ricerca e da quest’ultimo al nuovo “preruolo” delineato dal DDL Bernini non incide sulla drammatica percentuale del 90% di espulsione dal sistema della ricerca, che non dipende dall’ampliamento delle tutele nella fase iniziale del percorso accademico, bensì dalla sistematica assenza di politiche di reclutamento strutturale e ordinato che vadano a riassorbire, tramite nuovi posti in tenure, il precariato storico. È infatti il blocco dei piani assunzionali straordinari a impedire qualsiasi reale prospettiva di stabilizzazione, non certamente una posizione che, seppur non ancora implementata, viene de plano accusata di espellere dal sistema precari giovani e precari vecchi, cercando così di metterli gli uni contro gli altri alla ricerca di ancora maggiore flessibilità e svalutazione.
Secondo il Piano straordinario per l’università elaborato da FLC-CGIL, sarebbero necessari almeno 25.000 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo B (ora RTT) entro il 2027 per iniziare un processo di riassorbimento del precariato storico. Solo un piano di reclutamento ciclico, ordinato e pluriennale potrà garantire tre obiettivi strategici per il futuro dell’università italiana:
1. Copertura integrale del turnover determinato dai pensionamenti;
2. Abbassamento dell’età media del corpo docente, oggi tra le più alte d’Europa e dei Paesi OCSE;
3. Riequilibrio del rapporto docenti/studenti, attualmente attestato su un valore tra i più sfavorevoli nel contesto europeo (1 docente ogni 20 studenti).
Una riforma seria e lungimirante non può prescindere da queste priorità. È su questo terreno – quello della dignità del lavoro, della qualità della formazione e della sostenibilità del sistema – che si misura il futuro dell’università e della ricerca pubblica in Italia.
Il tentativo di sostituire il contratto di ricerca con nuove forme paracontrattuali a tutele decrescenti, contenuto nel disegno di legge AS 1240/2024, è stato fermato grazie a una mobilitazione plurale e determinata: dalle proteste delle componenti precarie della ricerca, al confronto costante nelle sedi istituzionali, fino agli esposti formali presentati da ADI e successivamente da FLC-CGIL alla Commissione Europea. Questo intervento coordinato ha condotto alla sospensione dell’iter legislativo, evitando, per il momento, l’approvazione di una norma che avrebbe compromesso anni di avanzamenti sul fronte dei diritti nel preruolo.
A fronte di ciò, la risposta politica è stata un atto ritorsivo: un progressivo disinvestimento sul sistema universitario, nella speranza che l’intero comparto – stremato dalla carenza di risorse – fosse costretto a chiedere un passo indietro rispetto all’unica vera innovazione normativa degli ultimi anni. Si è così cercato, nei fatti, di cancellare il contratto di ricerca, nonostante si tratti di uno strumento pienamente operativo, previsto per legge, coerente con gli obiettivi del PNRR, e già formalmente certificato dalla Corte dei Conti.
Con la Delibera n. 2/SSRRCO/CCN/2025 del 13 marzo 2025, la Corte dei Conti ha infatti preso atto dell’ipotesi contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010, come modificato dal d.l. 36/2022 (PNRR 2), riconoscendone la coerenza con il quadro normativo e finanziario vigente. Tale contratto, siglato il 9 ottobre 2024 e previsto dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, è nato proprio sulla base delle criticità emerse durante l’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e sul precariato nella ricerca universitaria conclusa dal Senato il 3 agosto 2021. L’indagine denunciava come gli assegni di ricerca costituissero una figura non strutturata, priva delle garanzie minime in materia di lavoro.
La stessa CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), aveva riconosciuto l’urgenza di una semplificazione e razionalizzazione delle forme contrattuali pre-ruolo, criticando pratiche che di fatto ritardano l’accesso stabile alla docenza. Allo stesso modo, la Corte dei Conti, nel Referto sul sistema universitario (maggio 2021), aveva evidenziato l’eccessiva lunghezza e frammentarietà del percorso di accesso al ruolo di professore associato, invocando una revisione del sistema basata su maggiore linearità, stabilità e selezione per merito.
Ignorare questo quadro significa rinnegare non solo un mandato politico e legislativo, ma anche un impegno vincolante assunto con l’Unione Europea attraverso il PNRR. Il contratto di ricerca non è una proposta ipotetica, ma uno strumento vigente, sostenuto da un impianto normativo chiaro, da un iter di contrattazione concluso, da una certificazione contabile favorevole e da una domanda concreta e diffusa nel sistema accademico.
Tentare di eluderlo attraverso tagli lineari, blocchi amministrativi, proroghe tutte politiche, o nuove figure spurie significa alimentare un sistema regressivo fondato sulla precarietà e sulla dipendenza strutturale di migliaia di giovani ricercatori da dispositivi lavorativi opachi, spesso subordinati a criteri non trasparenti. È un modello di in-accesso all’università che spinge intere generazioni ai margini, in presenza dei tanto decantati profili eccellenti, con percentuali di esclusione dal sistema superiori al 90%.
Lo ribadiamo con forza: il contratto di ricerca è già legge. È una milestone del PNRR. È stato riconosciuto come necessario dalla Corte dei Conti. È frutto di una battaglia politica e culturale decennale. Va applicato, non smantellato.
L’ADI, insieme a numerose realtà impegnate nella tutela dei diritti del personale precario della ricerca, ha sempre ribadito un principio fondamentale: la ricerca è lavoro, e chi lavora ha diritto a un contratto dignitoso, fondato sul rispetto della persona e conforme ai principi costituzionali e internazionali in materia di lavoro.
In questo quadro, le proposte volte a riesumare forme alternative al contratto di ricerca – giustificate con la loro presunta maggiore “economicità” – non rappresentano altro che un passo indietro rispetto alla rivendicazione di diritti minimi che da anni le organizzazioni rappresentative del precariato universitario avanzano in tutte le sedi. Non si tratta di una questione tecnica, ma di una precisa scelta di civiltà politica che il sistema della ricerca - i suoi ricercatori, in primis - meritano.
Occorre affermarlo con chiarezza: la carenza di fondi non è una condizione oggettiva, bensì il risultato di una deliberata decisione politica. La mancata volontà di investire in modo strutturale nell’università pubblica si traduce, da un lato, nella conservazione di un sistema che si regge su forza lavoro sottopagata, demansionata e priva di tutele – coerentemente con una tradizione che ha storicamente svalutato il lavoro intellettuale – e, dall’altro, nel consolidamento di un’accademia sempre più chiusa e ridotta, inaccessibile a chi non dispone delle risorse economiche per sopportare anche oltre un decennio di precarietà.
Se lo Stato assumesse pienamente la propria responsabilità istituzionale, chi completa un dottorato di ricerca potrebbe accedere a forme contrattuali trasparenti e tutelate, compatibili con una vita dignitosa e con la continuità del proprio progetto scientifico. Ne beneficerebbe non solo la qualità della ricerca, ma anche la crescita economica, sociale e culturale del Paese.
È paradossale – e per certi versi inaccettabile – dover ancora giustificare la necessità di investire nella ricerca e nel diritto allo studio in un contesto, come quello italiano, in cui l’università pubblica è tra le meno finanziate in Europa. Non si tratta di mancanza di risorse: secondo stime già allegate agli emendamenti al DDL 1240, sarebbero sufficienti 300 milioni di euro l’anno – una cifra del tutto sostenibile nel quadro del bilancio statale – per garantire la piena attuazione del contratto di ricerca a tutti gli assegnisti già presenti nelle università italiane.
Nel solo 2024, il recupero dell’evasione fiscale ha superato di 1,6 miliardi quello dell’anno precedente. A ciò si aggiunge la possibilità, già prevista dall’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, di recuperare almeno 1 miliardo di euro annui a partire dal 2025, attraverso una revisione progressiva dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), limitatamente a quelli che non incidono sulla tutela delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, come richiesto dalla Costituzione.
Infine, è utile ricordare che, sulla stessa linea di finanziamento dei contratti di ricerca previsti dal Decreto Direttoriale n. 47/2025, risultano già stanziati 105 milioni di euro (Investimento M4.C2.1.2 del PNRR – Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, Decreto MEF n. 7/2024).
Alla luce di questi dati, continuare a negare la possibile piena attuazione del contratto di ricerca – oggi già vigente, certificato dalla Corte dei Conti, e finanziariamente sostenibile – significa ignorare volontariamente le soluzioni disponibili, prolungando uno stato di precarietà strutturale che danneggia non solo migliaia di giovani ricercatori e ricercatrici, ma l’intero sistema universitario e il futuro stesso del Paese.
In ultima analisi, soltanto un’università statale che abbia ormai interiorizzato in modo estremo una visione aziendalistica – al punto da non riconoscersi più come parte integrante del settore pubblico – può considerare il contratto di ricerca un aggravio insostenibile per i propri bilanci. È vero che il costo lordo annuo di un contratto di ricerca si aggira intorno ai 40.000 euro, rispetto ai circa 24.000 euro di un assegno di ricerca. Tuttavia, tale differenziale è dovuto quasi interamente a una maggiore contribuzione lorda, che costituisce un beneficio per il sistema pubblico e non un onere aggiuntivo netto.
Dei 12.000 euro circa di oneri a carico delle amministrazioni, si stima infatti che:
-
9.050 euro siano destinati a contributi previdenziali, che alimentano direttamente il sistema pensionistico pubblico, consentendo il pagamento delle pensioni anche dei docenti attualmente in quiescenza e di quelli che saranno così collocati nei prossimi anni;
-
2.500 euro corrispondano all’IRAP, imposta il cui gettito è destinato in larga parte al finanziamento delle Regioni e, quindi, al sostegno dei servizi pubblici, inclusa l’università;
-
450 euro siano imputabili ai contributi per la futura indennità di disoccupazione, la quale – a differenza di quanto avviene con gli assegni di ricerca – è oggi finanziata dallo stesso contratto e rappresenta, pertanto, uno sgravio per la finanza pubblica.
A ciò si aggiunga che, sulla quota di retribuzione lorda (circa 28.000 euro), devono essere detratte l’IRPEF, che rientra nel bilancio statale, e i contributi previdenziali a carico del lavoratore (9,19%). Il risultato è un netto in busta paga, distribuito su tredici mensilità, che si avvicina a quello percepito con un assegno di ricerca, ma con la garanzia di diritti previdenziali, assistenziali e assicurativi oggi assenti.
Il contratto di ricerca, dunque, non rappresenta un incremento di spesa reale per lo Stato, ma una diversa articolazione delle voci di bilancio, a beneficio dell’intero sistema pubblico. Qualora si scegliesse di porre a carico diretto dello Stato gli oneri relativi ai contributi previdenziali e all’IRAP – come già avviene in ambito aziendale per alcune categorie di lavoratori – sarebbe possibile ulteriormente alleggerire i bilanci degli atenei, senza alcun sacrificio per la finanza pubblica.
Nel momento in cui, a livello europeo, si discute dell’adozione di un European Research Area Act, che mira a riconoscere la libertà della ricerca scientifica come fondamento dell’Unione e a uniformare gli standard di finanziamento e tutela, portando la spesa pubblica in ricerca e università al 3% del PIL, l’Italia sembra muoversi in direzione diametralmente opposta. Anziché consolidare il contratto di ricerca come strumento europeo pienamente in linea con tali obiettivi – in grado, tra l’altro, di garantire anche agli assegnatari di progetti Marie Skłodowska-Curie uno status contrattuale consono agli standard UE – si alimentano narrazioni fuorvianti.
Si insinua, ad esempio, che l’introduzione del contratto possa penalizzare i neodottorandi e favorire ricercatori più avanzati nella carriera. È una tesi strumentale, che dimentica come per questi ultimi andrebbero previste, in via ordinaria, posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo B (ora RTT), come indicato già dalla stessa Legge.
Dietro questa operazione si delinea un chiaro disegno ideologico: non espellere dal sistema i giovani ricercatori, ma trattenerli in condizioni di sfruttamento prolungato, negando loro il riconoscimento del lavoro che svolgono e impedendo alle università di assumere con strumenti già pienamente operativi. È una forma di ricatto sistemico che paralizza l’autonomia universitaria, intesa anche come libertà del ricercatore dal bisogno materiale, in qualunque fase della propria carriera.
Lo ripetiamo con fermezza: le università potrebbero assumere da domani con il contratto di ricerca, già attivo, finanziabile, conforme alla legge e compatibile con i vincoli europei. È il Governo che, consapevolmente, ne ostacola l’attuazione, scegliendo di non considerare la ricerca un lavoro degno di tutele.
Non vogliono espellerci più di prima, vogliono tenerci dentro sfruttatɜ e sottopagatɜ per più tempo possibile.
Pubblicato Lun, 31/03/2025 - 21:01
- Accedi o registrati per inserire commenti.